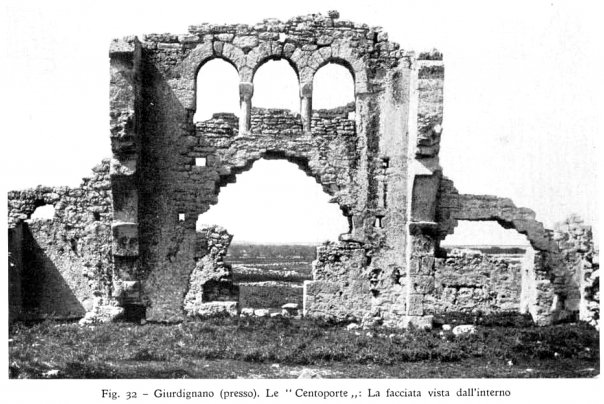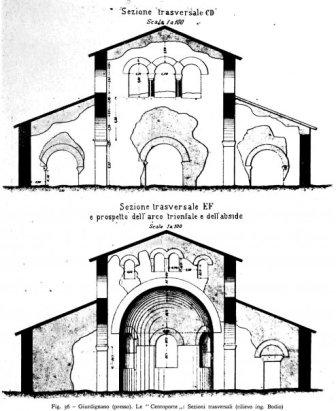La murtèddha

di Armando Polito
Con la frasca, di cui discorrerò in un successivo post, il mirto è tra le essenze fondamentali della macchia mediterranea.
Nome dialettale: murtèddha
nome italiano: mirto, mortella
nome scientifico: Myrtus communis L.
famiglia: Myrtaceae
Le denominazioni riportate derivano tutte dal latino myrtus a sua volta dal greco myrtos, che con lo stesso significato ha anche myrsìne o myrrìne. La nostra pianta non si sottrae al destino leggendario di personaggi mitici trasformati in vegetali e celebrati da autori più o meno famosi e più o meno antichi (due soli esempi: l’alloro in cui si muta Dafne per sfuggire alla libidine di Apollo, la canna in cui per pietà fu mutato da Zeus Calamo dopo la morte di Carpo); nel nostro caso la testimonianza è di epoca bizantina, anche se l’opera in cui è contenuta (Geoponica), compilazione risalente al X secolo, è frutto di precedenti stratificazioni: “Mirsìne era una fanciulla attica, che superava in bellezza tutte le ragazze e in forza tutti i ragazzi. Era pure devota alla dea Minerva e trascorreva il suo tempo nelle palestre e negli stadi e incoronava i giovani che gareggiavano e vincevano. Alcuni di loro vinti e superati, mossi da odio e invidia per la fanciulla, la uccisero. Ma non estinsero la riconoscenza di Minerva per la fanciulla, sicché ancora rimane preferito dalla dea il mirto al pari dell’olivo e, cambiata vita, invece delle olive esso produce le sue bacche”.1
Probabilmente la leggenda è molto più antica dell’opera che ce l’ha tramandata e quasi certamente è legata all’importanza che alla pianta gli antichi riconoscevano. Mi limito a riportare la corposa testimonianza di Plinio (I° secolo d. C.) perché essa compendia ogni conoscenza (anche di epoca a lui anteriore) con i suoi riferimenti simbolici e concreti: “La natura del succo è degna di eccezionale ammirazione nel mirto, dal momento che da questa sola specie si ricavano due tipi di olio e di vino, e ancora, come ho detto, il mirtidano2. E venne usato dagli antichi in sostituzione del pepe prima che venisse scoperto, viene esaltato il sapore della carne di cinghiale pure in un certo preparato che trae da esso il nome, dopo aver aggiunto per lo più mirti agli intingoli. Si tramanda che questo albero fu visto sotto il cielo dell’Europa più vicina, che inizia dai monti Cerauni3, per la prima volta a Circeo sulla sepoltura di Elpenore4 e gli resta il nome greco, per cui appare come una pianta straniera. Fu dove oggi è Roma già al momento della sua fondazione, poichè si tramanda che con un ramoscello di mirto Romani e Sabini, dopo che avevano voluto scontrarsi per il rapimento delle vergini, deposte le armi, si purificarono in quel luogo dove c’è la statua di Venere Cloacina; gli antichi infatti dicevano cluere per purgare. E pure in quell’albero c’è una specie di profumo e allora per questo fu scelto, poiché Venere presiede all’accoppiamento5 e a questo albero, non so se primo tra tutti piantato a Roma nei luoghi pubblici per un fatidico e memorabile augurio. Infatti si trova tra i santuari antichissimi di Quirino, cioé dello stesso Romolo. Lì davanti allo stesso tempio ci furono per lungo tempo due sacri mirti, uno chiamato patrizio, l’altro plebeo. Il patrizio durò molti anni esuberante e florido per tutto il tempo che anche il senato fiorì, grande, il plebeo inaridito e squallido. Dopo che questo si riprese mentre il patrizio ingialliva, a partire dalla guerra marsica s’indebolì l’autorità dei senatori e a poco a poco la sua maestà marcì in sterilità. Anzi ci fu anche una vecchia ara a Venere Mirtea, che ora chiamano Murcia. Catone ha tramandato tre tipi di mirto: il nero, il bianco, quello coniugale, probabilmente da coniugio, di quella specie del Cloacino. Ora anche l’altra distinzione del coltivato e del selvatico e nell’uno e nell’altro di quella a foglia larga, nel selvatico particolare quella del pungitopo. I giardinieri considerano specie coltivate la tarantina dalla foglia minuta, la nostrale dalla foglia larga, la esastica dal fogliame densissimo, con sei ordini per volta. Questa non viene usata, è ricca di rami e non alta. Credo che ora la coniugale è chiamata nostrale. Il mirto è profumatissimo in Egitto. Catone ha insegnato che si ricava il vino da quello nero seccato all’ombra e aggiunto al mosto. Se le bacche non vengono seccate se ne ricava olio. Poi si scoprì che anche dalla bianca si ricava vino bianco, con due sestari di mirto pestato macerato e poi spremuto in due emine di vino. Le foglie pure vengono essiccate in farina a rimedio delle ferite nel corpo umano, con una polvere leggermente pungente e che placa la sudorazione. Anche nell’olio, strano a dirsi, c’è un certo sapore di vino e nello stesso tempo un liquido grasso con la principale proprietà di correggere il vino filtrato attraverso un sacco. Trattiene la feccia e lascia passare solo il liquido puro e si offre come compagno con ottime referenze al filtrato. Anche le sue bacchette, solo portate, giovano a chi procede a piedi in un lungo viaggio; anzi pure gli anelli fatti col ramoscello privi di ferro curano i rigonfiamenti dell’inguine. Anche in campo bellico è entrato e trionfando sui Sabini P. Postumio Tuberto durante il suo consolato, egli che primo tra tutti entrò in città con l’onore dell’ovazione, poiché aveva condotto agevolmente l’impresa senza spargimento di sangue, coronato del mirto di Venere vincitrice avanzò e rese desiderabile quest’albero pure ai nemici. Questa fu poi la corona di coloro che godevano dell’ovazione, eccetto M. Crasso che dopo avere trionfato su Spartaco e gli schiavi fuggitivi avanzò incoronato di alloro. Masurio scrive che anche coloro che trionfavano sul carro usarono una corona di mirto. L. Pisone tramanda che Papirio Masone, che per primo sul monte Albano trionfò sui Corsi, era solito assistere ai giochi del circo coronato di mirto. Questi era l’avo materno dell’Africano minore. Marco Valerio usava due corone, di alloro e di mirto, perché l’aveva promesso in voto.
L’integrazione delle proprietà terapeutiche del mirto trova spazio in numerosi altri passi, a curare (come estratto oleoso) i disturbi più disparati in combinazione con altre essenze (angina: XX, 56; occhi gonfi: XXII, 68; colera e dissenteria; XXII, 70) o da solo (gengivite, odontalgia, dissenteria, ulcerazioni uterine, cistite, scottature, lesioni da attrito, forfora, ragadi, condilomi, lussazioni, contro la puntura di cantaride e buprestide e sostanze urticanti, come deodorante: XXIII, 44).
Ecco, poi, notizie sulla preparazione e sull’uso del mirtidano: “Fra poco diremo in che modo secondo Catone viene preparato il vino al mirto, i Greci lo fanno in altro modo. Dopo aver pestato i rami teneri cotti con le loro foglie in mosto salato, ne bolliscono una libbra in tre congi di mosto, finché ne restano due. Quello che nello stesso modo viene fatto dalle bacche del mirto selvatico si chiama mirtidano. Esso tinge le mani”7; “Abbiamo detto in che modo si fa il mirtidano. Giova alla matrice riscaldato ed applicato ad empiastro, molto più efficace anche con la corteccia, le foglie e il seme. Viene estratto anche il succo dalle foglie tenerissime pestate in un mortaio, versando poco a poco vino aspro o altrimenti acqua piovana: e di questo succo si servono contro le ulcere della bocca e del sedere, della matrice e del ventre, per far diventare neri i capelli, come astringente per il viso, per schiarire le lentiggini e ogni qualvolta si abbia bisogno di un astringente”.8
Nell’opera di Plinio, inoltre, il mirto compare a modello di comparazione nella descrizione di altre piante, a riprova dell’enorme considerazione in cui era tenuto: rhus (XXIV, 54), heliantes (XXIV, 102), chamaerops (XXVII, 69), polyrrhizon (XXVII, 103).
Le proprietà terapeutiche di questa pianta in veterinaria sono attestate dal contemporaneo Columella che contro la dissenteria nel bue consiglia: “Né manchino germogli di lentisco e mirto e di verde olivastro”; “Devono essere somministrati germogli di olivastro e di canna, allo stesso modo bacche di lentisco e di mirto”.9 Lo stesso autore ci informa dell’importanza del mirto nell’alimentazione dei colombi (“Molti ritengono che dev’essere offerta una varietà di cibi per evitare che quando è unico manifestino avversione. Questo si evita quando si gettano loro semi di mirto e lentisco, oppure bacche di olivastro e di edera, nonché di corbezzolo”10), del suo utilizzo nella costruzione di arnie (“…le celle in cui nidifichino le api ed esse siano coperte da arbusti di bozzo o di mirto piantati in mezzo, che non superino l’altezza delle pareti”11), per aromatizzare il vino (“Prima di togliere il mosto dal tino riempi pure in abbondanza i contenitori di rosmarino o di alloro o di mirto affumicato affinché il vino fermentando si purifichi bene; poi strofina leggermente i contenitori con pigne”12). Le sue indicazioni sulla preparazione del vino al mirto (addirittura quattro procedure!) sono molto più precise ed esaurienti di quelle di Plinio: “Prepara così il vino al mirto utile contro le coliche, la diarrea e il mal di stomaco: due sono le specie di mirto, il nero e il bianco. Si raccolgono le bacche del nero quando sono mature, se ne estraggono i semi e così vengono essiccate al sole e conservate in un vaso di creta in luogo asciutto. Poi durante la vendemmia da un vecchio ceppo o, se non c’è, dalle vecchissime vigne di Aminea si raccolgono uve maturate al calore del sole e il mosto da esse estratto viene messo in un barile e subito nel primo giorno, prima che inizi la fermentazione, bacche di mirto, prima messe da parte, vengono accuratamente pestate e si pesano di queste tante libbre quante sono le anfore da trattare; allora viene preso un pò di mosto dal barile che ci accingiamo a trattare e viene sparsa come farina ciò che è stato pestato e pesato. Dopo di ciò dalla massa si ricavano dei pezzetti e così vengono messi nel mosto del barile ai margini facendo attenzione che ogni pezzetto non vada a finire sopra l’altro. Quando il mosto sarà fermentato e filtrato due volte di nuovo allo stesso modo e nella stessa misura vengono pestate le bacche ma questa volta non si fanno pezzetti ma viene versato il mosto dal barile in una coppa, viene mescolato con le bacche finché non assume le sembianze di un brodo grasso; quando la miscela è pronta si versa nel barile e si gira con un mestolo di legno. Poi dopo nove giorni il vino viene filtrato e il barile viene strofinato leggermente con ramoscelli di mirto secco e viene apposto un coperchio perché niente vi caschi dentro. Fatto ciò, dopo sette giorni il vino viene di nuovo filtrato e versato in anfore ben impeciate e profumate; ma bisogna fare attenzione, quando i versa, a non versare anche la feccia. Prepara così un altro vino al mirto: fai bollire tre volte miele attico e togli la schiuma altrettante volte. Oppure se non ha il miele attico scegli il migliore e togli la schiuma quattro o cinque volte, poiché, quanto più è di qualità scadente tante più impurità ha. Quando il miele si è raffreddato scegli bacche di mirto bianco quanto più possibile mature e strofinale per evitare di pestare i semi che si trovano all’interno. Poi dopo averle messe in una fiscella spremile e mescola il succo, che dev’essere nella quantità di sei sestari, con un sestario di miele bollito, versalo in una bottiglietta e tappala. Questo però deve essere fatto nel mese di dicembre, tempo in cui sono maturi i semi del mirto e bisogna fare attenzione che per sette giorni prima che le bacche siano raccolte (se è possibile, altrimenti per non meno di tre) il tempo sia stato sereno o almeno non abbia piovuto; e bisogna fare attenzione a non raccoglierle se sono bagnate di rugiada. Molti spremono la bacca nera o bianca del mirto quando è matura e, dopo averla seccata un pò all’ombra per due ore, la schiacciano in modo che, per quanto è possibile, i semi interni restino integri; a questo punto spremono per mezzo di una fiscella la massa pestata e attraverso un filtro di giunco versano il succo purificato in bottigliette ben impeciate, senza aggiungere miele né altro. Questo liquido non dura tanto a lungo (ma talvolta può durare senza pericolo) è più utile alla salute che il composto dell’altro mirto conosciuto. Ci sono quelli che, quando il succo estratto è abbondante, lo fanno bollire fino a ridurlo ad un terzo e dopo che è raffreddato lo mettono in bottigliette impeciate; così confezionato dura più a lungo. Ma anche se non è stato fatto bollire può durare senza pericolo per due anni, a patto che sia stato preparato igienicamente ed accuratamente”13.
E poteva mancare all’appuntamento con la nostra mortella Apicio, il cuoco più famoso dell’antichità? Le bacche compaiono ripetutamente tra gli aromi nella preparazione di salse che accompagnano sia la carne (“Altra salsa bianca per carni tagliuzzate: pepe, timo, cumino, semi di sedano, finocchio, rita oppure menta, bacche di mirto, uva passa: tempera con vino melato e agita con un ramo di santoreggia”14; “Salsa per carni tagliuzzate: affetta uova sode, pepe, cumino, prezzemolo, porro cotto, bacche di mirto un pò di più, miele, aceto, sugo di acciughe, olio.”15) che il pesce (“Salsa per orata: pepe, ligustico, carvi, origano, bacca di ruta, menta, bacca di mirto, tuorlo d’uovo, miele, aceto, olio, vino, sugo di acciughe. Scaldala e utilizzala così”16), come la cacciagione in genere (“Pepe, cumino fritto, ligustico, menta, uva passa snocciolata o prugne di Damasco, miele in piccola quantità. Lavora il tutto con vino al mirto, aceto, sugo di acciughe e olio. Riscalda e rimesta con sedano e satureia”17) e in particolare la pernice (“Pepe, ligustico, seme di sedano, bacche di mirto o uva passa, miele, vino, aceto, sugo di alici e olio. Utilizzalo freddo”18) e il cinghiale (“Altra salsa per cinghiale: trita pepe, ligustico, origano, bacche di mirto snocciolate, coriandro, cipolla; versa miele, vino, sugo di alici, olio in piccola quantià; riscalda, adensa con amido, versa sul cinghiale cotto in forno. Questa salsa va bene per ogni tipo di selvaggina19”).
E, dopo i pagani, un autore cristiano, Sant’Agostino, sceglie il mirto per spiegare, addirittura, il concetto della Trinità: “Diciamo poi che l’alloro, il mirto e l’olivo sono solo tre alberi o tre essenze o nature…Ma dove non c’è nessuna diversità di natura così generalmente vengono chiamate parecchie cose che possono essere pure chiamate con nomi particolari. La differenza di natura infatti fa sì che l’alloro, il mirto e l’olivo o il cavallo, il bue e il cane non siano indicati con un nome speciale (le piante tre allori o gli animali tre buoi) ma generale (le piante tre alberi e gli animali tre animali)”20.
Per tutto il medioevo e buona parte dell’età moderna particolare successo ebbe tra i prodotti cosmetici come purificante e tonificante della pelle l’Acqua degli angeli, distillato delle foglie e dei fiori del mirto.
In epoca più recente particolare successo commerciale ha riscosso il liquore di mortella sardo (non è per stupido campanilismo, ma quello che prepara in casa mia moglie è di gran lunga migliore…). E poi, come non dire che mortadella non è altro che il diminutivo del latino murtàtum=insaccato condito con mirto, anche se di mirto (e forse anche di carne…) oggi non c’è nemmeno l’ombra?
_______
1 XI, 6; traduco il testo greco riportato nell’edizione a cura di P. Nehedam uscita a Cambridge nel 1704 per i tipi dell’Accademia , pagg. 305-306.
2 I branI relativI alla sua preparazione e agli usi terapeutici sono riportati più avanti.
3 In Epiro.
4Uno dei compagni di Ulisse.
5 Vedi più avanti il mirto coniugale che Plinio riporta da Varrone.
6 Naturalis historia, XV, 35-38: Sucorum natura praecipuam admirationem in myrto habet, quando ex una omnium olei vinique bina genera fiunt, item myrtidanum, ut diximus. Et alius usus bacae fuit apud antiquos ante quam piper reperiretur illam optinens vicem, in quodam etiam genere opsonii nomine inde tracto, aprorum sapor commendatur, plerumque ad intinctus additis myrtis. Arbor ipsa in Europae citeriore caelo, quod a Cerauniis montibus incipit, primum Cerceis in Elpenoris tumulo visa traditur Graecumque ei nomen remanet, quo peregrinam esse apparet. Fuit, ubi nunc Roma est, iam cum conderetur; quippe ita traditur, myrtea verbena Romanos Sabinosque, cum propter raptas virgines dimicare voluissent, depositis armis purgatos in eo loco qui nunc signa Veneris Cluacinae habet; cluere enim antiqui purgare dicebant. Et in ea quoque arbore suffimenti genus habetur, ideo tum electa, quoniam coniunctioni et huic arbori Venus praeest, haud scio an prima etiam omnium in locis publicis Romae sata, fatidico quidem et memorabili augurio. Inter antiquissima namque delubra habetur Quirini, hoc est ipsius Romuli. In eo sacrae fuere myrti duae ante aedem ipsam per longum tempus, altera patricia appellata, altera plebeia. Patricia multis annis praevaluit exuberans ac laeta; quamdiu senatus quoque floruit, illa ingens, plebeia retorrida ac squalida. quae postquam evaluit flavescente patricia, a Marsico bello languida auctoritas patrum facta est ac paulatim in sterilitatem emarcuit maiestas. quin et ara vetus fuit Veneri Myrteae, quam nunc Murciam vocant. Cato tria genera myrti prodidit, nigram, candidam, coniugulam, fortassis a coniugiis, ex illo Cluacinae genere. Nunc et alia distinctio sativae aut silvestris et in utraque latifoliae, in silvestri propria oxymyrsinae. Sativarum genera topiarii faciunt Tarentinam folio minuto, nostratem patulo, hexasticham densissimo, senis foliorum versibus. Haec non est in usu, ramosa atque non alta. Coniugalem existimo nunc nostratem dici. Myrtus odoratissima Aegypto. Cato docuit vinum fieri e nigra siccata usque in ariditatem in umbra atque ita musto indita. Si non siccentur bacae, oleum gigni. Postea conpertum et ex alba vinum fieri album, duobus sextariis myrti tusae in vini tribus heminis maceratae expressaeque. Folia et per se siccantur in farinam ad ulcerum remedia in corpore humano, leniter mordaci pulvere, ac refrigerandis sudoribus.Quin immo oleo quoque, mirum dictu, inest quidam vini sapor simulque pinguis liquor, praecipua vi ad corrigenda vina saccis ante perfusis. Retinet quippe faecem nec praeter purum liquorem transire patitur datque se comitem praecipua commendatione liquato. Virgae quoque eius, gestatae modo, viatori prosunt in longo itinere pediti; quin et virgei anuli expertes ferri inguinum tumori medentur. Bellicis quoque se rebus inseruit, triumphansque de Sabinis P. Postumius Tubertus in consulatu, qui primus omnium ovans ingressus urbem est, quoniam rem leniter sine cruore gesserat, myrto Veneris victricis coronatus incessit optabilemque arborem etiam hostibus fecit. Haec postea ovantium fuit corona excepto M. Crasso, qui de fugitivis et Spartaco laurea coronatus incessit. Masurius auctor est curro quoque triumphantes myrtea corona usos. L. Piso tradit Papirium Masonem, qui primus in monte Albano triumphavit de Corsis, myrto coronatum ludos Circenses spectare solitum; avus maternus Africani sequentis hic fuit. Marcus Valerius duabus coronis utebatur, laurea et myrtea, qui et hoc voverat.
7 XIV, 103 Myrtiten Cato quem ad modum fieri docuerit mox paulo indicabimus, Graeci et alio modo. Ramis teneris cum suis foliis in salso musto coctis tunsis, libram in tribus musti congiis defervefaciunt, donec duo supersint. Quod ita e silvestris myrti bacis factum est, myrtidanum vocatur. Hoc manus tinguit.
8 XXIII, 82: Myrtidanum diximus quomodo fieret. Vulvae prodest, adpositu, fotu, et illitu. Multo efficacius est cortice et folio et semine. Exprimitur ex foliis succus mollissimis in pila tusis, adfuso paulatim vino austero, alias aqua coelesti: atque ita expresso utuntur ad oris sedisque ulcera, vulvae et ventris: capillorum nigritiam, malarum perfusiones, purgationem lentiginum et ubi constringendum aliquid est.
9 De re rustica, VI, 2 Nec desint lentisci myrtique et oleastri cacumina viridis; VI, 3 Cacumina oleastri et arundinis, item baccae lentisci et myrti dandae.
10 Op.cit., VIII, 4 Multi varietatem ciborum, ne unum fastidiant, praebendam putant. Ea est cum obiciuntur myrti et lentisci semina, item oleastri et hederaceae baccae nec minus arbuti.
11 Op. cit., VIII, 5 …cubilia quibus innidificent aves, eaque contegantur intersitis buxeis vel myrteis fruticibus, qui non excedant altitudinem parietum.
12 Op. cit., XII, 4 Mustum autem antequam de lacu tollas, vasa rore marino vel lauro vel myrto subfumigato et large repleto, ut in effervescendo vinum se bene purget; postea vasa nucibus pineis suffricato.
13 Op. cit., XII, 38, 1-8 Vinum myrtitem ad tormina et ad alvi proluviem et ad inbecillum stomachum sic facito: duo genera sunt myrti, quorum alterum est nigrum, alterum album. Nigri generis bacae, cum sunt maturae, leguntur, et semina earum eximuntur, atque ipsae sine seminibus in sole siccantur, et in fictili fidelia sicco loco reponuntur. [2] Deinde per vindemiam ex vetere arbusto vel, si id non est, ex vetustissimis vineis Amineae bene maturae uvae sole calido leguntur, et ex is mustum adicitur in seriam et statim primo die, antequam id ferveat, bacae myrti, quae fuerant repositae, diligenter conteruntur et totidem earum librae contusarum appenduntur, quot amphorae condiri debent; tum exiguum musti sumitur ex ea seria, quam medicaturi sumus, et tamquam farina conspargitur, quicquid contusum et appensum est. Post hoc complures ex ea massulae fiunt et ita per latera seriae in mustum demittuntur, ne altera offa super alteram perveniat. [3] Cum deinde bis mustum deferbuerit et bis curatum est, rursus eodem modo et tantundem ponderis bacae, sicut supra, contunditur, nec iam, ut prius, massulae fiunt, sed in labello mustum de eadem seria sumitur, praedicto ponderi permiscetur, sicut sit instar iuris crassi; quod cum est permixtum, in eandem seriam confunditur et rutabulo ligneo peragitatur. [4] Deinde post nonum diem, quam id factum est, vinum purgatur et scopulis aridae myrti seria suffricatur operculumque superponitur, ne quid eo decidat. Hoc facto, post septimum diem rursus vinum purgatur et in amphoras bene picatas et bene olidas diffunditur; sed curandum est, ut, cum diffundis, liquidum et sine faece diffundas. [5] Vinum aliud myrtiten sic temperato. Mel Atticum ter infervere facito et totiens despumato. Vel si Atticum non habueris, quam optimum mel eligito et quater vel quinquies despumato, quoniam, quanto est deterius, tanto plus habet spurcitiae. Cum deinde mel refrixerit, bacas albi generis myrti quam maturissimas legito et perfricato, ita ne interiora semina conteras. [6] Mox fiscello ligneo inclusas exprimito, sucumque earum, qui sit sextariorum sex, cum mellis decocti sextario misceto et in lagunculam diffusum oblinito. Sed hoc mense Decembri fieri debebit, quo fere tempore matura sunt myrti semina, custodiendumque erit, ut, antequam bacae legantur, si fieri potest, VII diebus, sin autem, ne minus triduum serenum fuerit aut certe non pluerit; et, ne rorulentae legantur, cavendum. Multi nigram vel albam myrti bacam, cum iam maturuit, destringunt et, duabus horis eam cum paululum in umbra expositam siccaverunt, proterunt, ita ut, quantum fieri potest, interiora semina integra permaneant; tum per lineum fiscum, quod protriverant, exprimunt et per colum iunceum liquatum sucum lagunculis bene picatis condunt neque melle neque alia re ulla inmixta. Hic liquor non tam est durabilis, sed quamdiu sine nox[i]a manet, utilior est ad valitudinem quam alterius myrtitis notae compositio. Sunt qui hunc ipsum expressum sucum, si sit eius copiosior facultas, in tertiam partem decoquant et refrigeratum picatis lagunculis condant; sic confectum diutius permanet. Sed et, quod non decoxeris, possit innoxium durare biennio, si modo munde et diligenter id feceris.
14 VII, 6, 7 Aliter ius candidum in copadiis: piper, thymum, cuminum, apii semen, foeniculum, rutam alias mentham, baccam myrteam, uvam passam; mulso temperabis, agitabis ramo satureiae.
15 VII, 6, 12 Ius in copadiis: ova dura incidis; piper, cuminum, petroselinum, porrum coctum, myrti baccas plusculum, mel, acetum, liquamen, oleum.
16 X, 12 Ius in pisce aurata: piper, ligusticum, careum, origanum, rutae bacam, mentam, myrtae bacam, ovi vitellum, mel, acetum, oleum, vinum, liquamen. calefacies et sic uteris.
17 VI, 5, 1 Ius in diversibus avibus: piper, cuminum frictum, ligusticum, mentham, uvam passam enucletam aut damascena, vel modice; vino myrteo temperabis, aceto, liquamine et oleo; calefacies et agitabis apio et satureia.
18 VI, 3 Piper, ligusticum, apii semen, mentam, myrti bacas vel uvam passam, mel, vinum, acetum, liquamen et oleum. Uteris frigido.
19 Aliter in apro: teres piper, ligusticum, origanum, baccas myrti exenteratas, coriandrum, cepas; suffundes mel, vinum, liquamen, oleum modice: calefacies, amylo obligas, aprum in furno coctum perfundes. Hoc et in omne genus carnis ferinae facies.
20 De Trinitate VII, 7: …laurum vero et myrtum et oleam, tantum tres arbores vel tres substantias aut naturas…. Sed ubi est naturae nulla diversitas ita generaliter enuntiantur aliqua plura ut etiam specialiter enuntiari possint. Naturae enim differentia facit ut laurus et myrtus et olea, aut equus et bos et canis non dicantur speciali nomine, istae, tres lauri, aut illi, tres boves, sed generali, et istae, tres arbores, et illa, tria animalia.