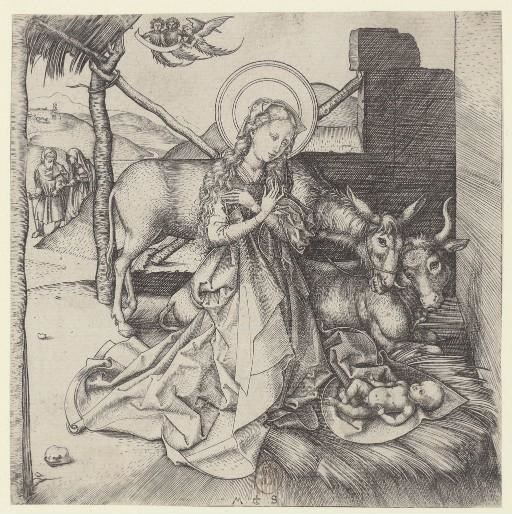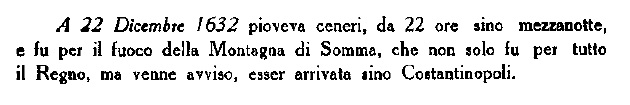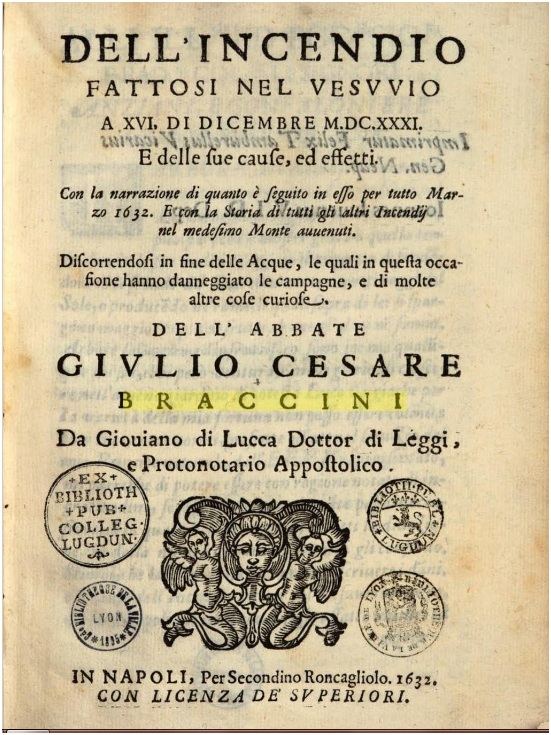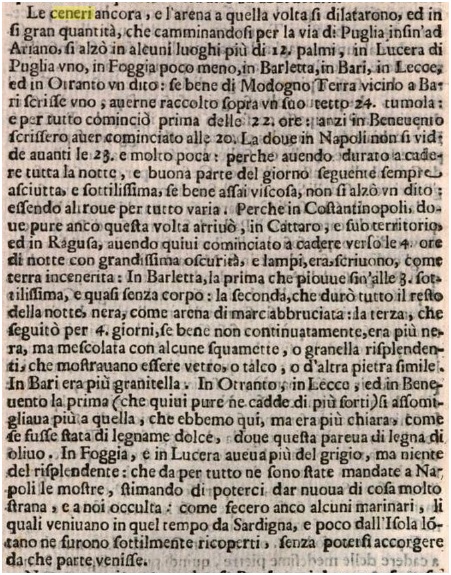di Armando Polito
Il periodo festivo è ormai alle nostre spalle e probabilmente nel corso di qualche riunione conviviale qualcuno più giovane non indaffarato nell’uso del telefonino sarà sobbalzato nel sentire dalla nonna (più difficile dalla madre, capace, come me, di preparare solo un uovo alla coque …) un’espressione del tipo – Mannaggia, lu nnaspru m’è bbissutu fiaccu! – (- Maledizione, la glassa mi è uscita male! -). Se al sobbalzo sarà seguito il desiderio di soddisfare il sentimento di sana curiosità ormai in via di estinzione anche presso i non più giovani, si sarà sentita nell’aria un’espressione più o meno come questa : – Nnaspru? E cce ggh’è? – (‘Nnaspru? E che è? -). A quel punto la vecchietta avrà avuto il suo momento di gloria nel fornire la definizione accurata del vocabolo e anche la giustificazione, autodiagnosi impietosa, del difetto manifestato (forse solo alla sua vista o al suo palato …) dal dolce che aveva preparato con tanto amore. Nel frattempo il nipote sarà già tornato ad armeggiare con il suo giocattolo preferito e il resto della compagnia avrà fatto finta di seguire con attenzione e rispetto la lezione della vecchietta. C’è da giurare, però, che nessuno dei commensali si sarà chiesto o avrà chiesto l’origine di nnaspru; e non certo perché impegnato nella degustazione di un altro dolce senza nnaspru o tutto concentrato sulla prossima bottiglia da stappare … Ancor meno probabile che guardando dalla finestra, proprio nel giorno dell’Epifania, il paesaggio imbiancato dalla neve, cosa molto rara dalle nostre parti, vi abbia visto un meraviglioso nnaspru confezionato da madre Natura.
Le feste son finite ma la rottura di scatole è già ricominciata, protagonista il sottoscritto. Comunque, non obbligo nessuno a procedere nella lettura, anche se qualcuno che mi ha seguito fino ad ora potrebbe far parte, magari, di quella schiera di improvvisati filologi che in questi giorni sull’origine di nnaspru si sono avventurati in rete, ma senza rete, nelle proposte più assurde. Dei loro parti, ma solo per motivi di spazio più che per carità cristiana, non riporterò, contrariamente al mio solito, nessuna schermata, ma tenterò per quanto è nelle mie capacità, di far luce su questa parola, partendo da chi, salentino come me, ha interessi di questo tipo.
Nel Dizionario Leccese-italiano di Antonio Garrisi, Capone, Cavallino, 1990) consultabile anche in linea in http://www.antoniogarrisiopere.it/) si legge: “nnaspru sm. Glassa, una specie di gelatina a base di zucchero, adoperata per rivestire dolciumi“. Non compare, dunque, nessuna proposta etimologica.
Ecco, invece, quella avanzata da Giuseppe Presicce nel suo Il dialetto salentino come si parla a Scorrano (http://www.dialettosalentino.it/a_1.html): “dal verbo nnasprare“. E al lemma nnasprare: “riteniamo derivi dal verbo latino asperare, nel senso di indurire, con il prefisso in- (nn per aferesi e raddoppiamento)“.
Pur condividendo, come si vedrà più avanti, il passaggio finale, solo quello, del Presicce, non capisco, però, come ad entrambi non sia venuto in mente, a quanto pare, di ascoltare, prima di affrettate conclusioni, la voce di colui che ancora oggi in questo campo rimane il maestro indiscusso, pur non essendo né salentino né italiano, ma tedesco: il Rohlfs. Nel suo Vocabolario dei dialetti salentini uscito per i tipi di Congedo a Galatina nell’ormai lontano 1976, nel terzo volume, che funge da appendice, al lemma ·naspro si legge:
“(L 15) chiara d’uovo. – Voce errata; si legga aspro“.
Il puntino prima del lemma sta ad indicare che si tratta di parola usata soltanto nei dialetti greci di Terra d’Otranto.
La sigla L 15 sta a significare che la voce non è stata raccolta direttamente sul campo, cioè dal parlato, ma è citazione da opera altrui, nel nostro caso da Materiali lessicali e folkloristici greco-otrantini raccolti da Pasquale Lefons e da altri e pubblicati da Giuseppe Gabrieli per i tipi di Garroni a Roma nel 1931.
Debbo osservare, innanzitutto, che non condivido l’etichetta rohlfsiana di voce errata (da intendersi credo, come erroneamente trascritta), non solo perché a Nardò si dice nnaspru e non aspru, ma perché naspro è voce abbondantemente attestata nell’italiano di qualche secolo fa, il che mette quanto meno in dubbio il limite linguistico-territoriale della Terra d’Otranto. La testimonianza letteraria più antica che son riuscito a trovare è in La singolare dottrina di M. Domenico …, Tramezzino, Venezia, 1570, s. p.:
Il Rohlfs riteneva che la forma corretta fosse aspro, ove si legge (la voce, come la precedente, è preceduta dal puntino): “(L 15, 55, cl,co, cz, z) ag. bianco; aspro ène to gala (L 55) bianco è il latte; to vùin aspro (L cl), to vidi t’aspro (L cs, z) il bue bianco; t’aspro (L co) la chiara dell’uovo [gr. ἄσπρος]“.
Probabilmente considerava errato naspro proprio per via di n iniziale. Essa, invece, può considerarsi derivata dalla preposizione, sempre greca, ἐν (leggi en), cui corrisponde il latino in, da cui la preposizione italiana. Da ἐν+ἄσπρος per aferesi di ἐ si è passati a νάσπρος, da cui il dialettale nnaspru con raddoppiamento di n a compensare la precedente aferesi. La conclusione, comunque, è che nnaspru deriva dal greco bizantino: infatti l’attestazione più antica di ἄσπρος citato dal Rohlfs risale a Teofane (VIII-IX secolo).
Tuttavia, prima di chiudere, non posso tacere di una cosa curiosa e che farà ringalluzzire chi pensa che il denaro è tutto nella vita: il greco-bizantino ἄσπρος deriva dal latino asper=ruvido. I Romani, infatti, chiamavano asperi nummi le monete fresche di conio, non ancora levigate dall’uso, quelle che in italiano sono dette ruspe (probabilmente dal longobardo ruspi=sporco). La voce latina, passò nel greco prima ad indicare le monete d’argento, poi ad assumere il significato più generico di bianco1, quello messo in campo per il nostro nnaspru, per cui risulta poco plausibile, nonostante l’evoluzione appena ricordata di moneta ruvida>moneta d’argento>bianco, la proposta del Presicce col passaggio dal concetto di inasprire a quello di indurire, anche perché l’ingrediente irrinunciabile per la glassa è lo zucchero, notoriamente bianco2; il fatto, poi, che la glassa stessa possa assumere un altro colore con l’aggiunta, per esempio, di cioccolato, rientra nella normale evoluzione di ogni preparato di base.
Non mi è stato facile, comunque, stendere questa nota etimologica, Sarà più facile, invece, individuare l’errore commesso dalla nonnina dell’inizio per chi, professionista nel settore, se ne intende o per chi ha fatto tesoro degli insegnamenti della nonna o per la stessa nonnina di prima. Mi piace immaginarla pure tecnologica quanto basta perché, dopo aver letto queste righe, intervenga personalmente; altrimenti, dopo averla messa al corrente, si faccia vivo qualche figlio o nipote. E così, oltretutto, l’ultimo modello dell’ultima generazione di telefonini, di cui va orgoglioso, paradossalmente servirà a ridurre il gap più pericoloso che esista tra le generazioni, compresa la mia, che è riuscita a collezionare più colpe che meriti: quello affettivo, che, poi, in questo caso, ma, in fondo, in tutti, è anche culturale.
____
1 Illuminante, a tal proposito, è quanto si legge nel Glossarium mediae et infimae Latinitatis del Du Cange (la traduzione a fronte è mia):
2 Glassa è dal francese glace, a sua volta dal latino glacie(m)=ghiaccio, anche se in questo vocabolo il concetto di duro (per il Presicce sviluppo di aspro) è prevalente su quello di bianco.