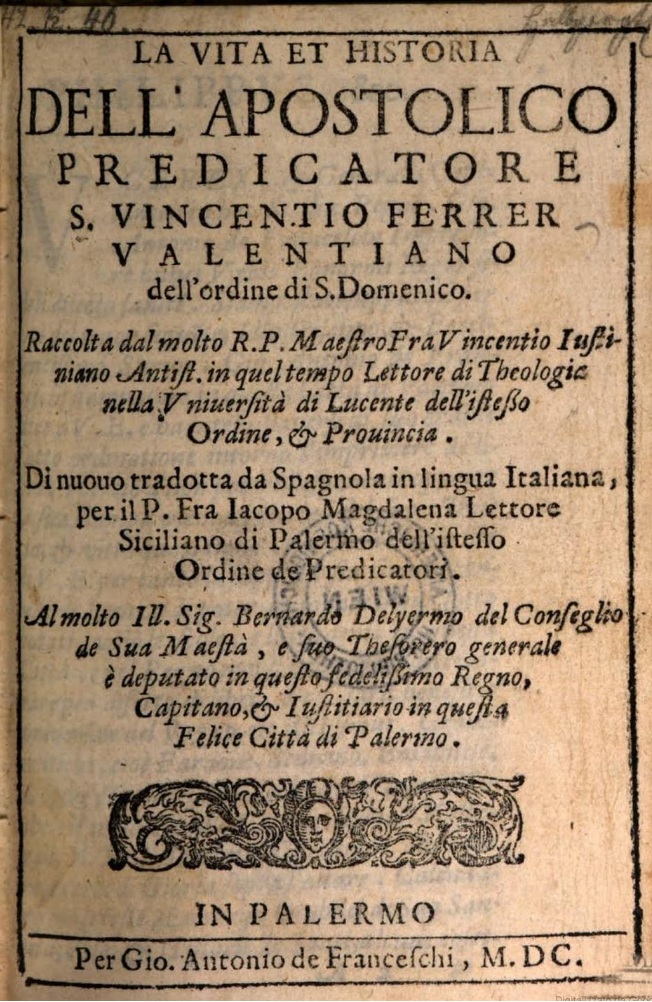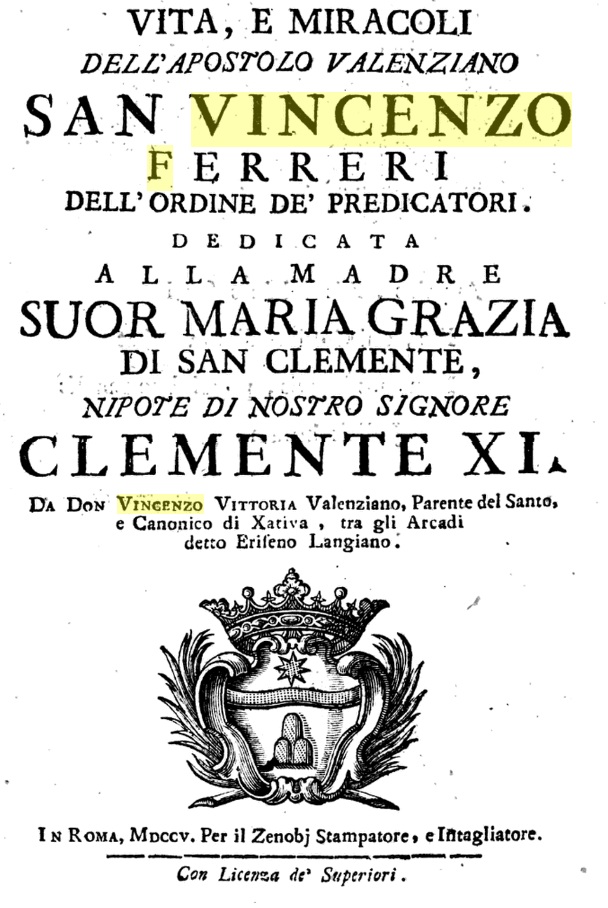di Marcello Gaballo e Armando Polito
Non è raro ancora oggi incontrare in pubblicazioni di carattere letterario e storico-scientifico se non vere e proprie dediche, espressioni di ringraziamento allo sponsor privato o a qualche ente pubblico patrocinatore a vario titolo, non escluso, in qualche caso quello economico. Dobbiamo dire, però, che tale fenomeno ha negli ultimi tempi registrato un drastico calo, che non crediamo sia da attribuire più di tanto ai morsi della crisi, ma piuttosto, purtroppo, alla scarsa considerazione in cui il prodotto culturale di un certo livello è precipitato.
Il confronto con il passato, sotto questo punto di vista, è impietoso e, senza andare troppo lontano scomodando Augusto e Mecenate e per restare al secolo di nostro interesse, basta ricordare che in pratica non c’è quasi pubblicazione risalente al XVII secolo che non contenga all’inizio una corposa dedica a questo o a quel personaggio, naturalmente importante. Saremmo ipocriti se non ammettessimo che, sostanzialmente, tutto è sotteso e condizionato dal do ut des, nel senso che il dedicatore e il dedicatario erano legati da un doppio filo: il primo da quello della speranza di ottenere qualche privilegio, favore o protezione; il secondo dal ritorno d’immagine, tanto più quando, oltre la dedica, era l’intera opera o una cospicua parte di essa a celebrare la sua persona.
Altra cosa sono gli esiti artistici, perché non tutti possono essere all’altezza di Virgilio, capaci, cioè di sganciarsi dalla contingenza e dall’individualismo della celebrazione per toccare corde universali e, in un certo senso, senza tempo.
Non lo è neppure l’autore che stiamo per presentare Perché lo facciamo, allora? Perché qualsiasi creazione artistica, anche se non è un capolavoro, è, pur sempre, figlia del suo tempo e, dunque, preziosa per la ricostruzione della relativa temperie spirituale, a parte l’aiuto che non pochi dettagli possono offrire per certi approfondimenti, conferme o smentite di verità che sembrano irreversibilmente consolidate dalla storia ed in essa registrate.
Vedremo così, attraverso la lettura diretta, come il nostro autore non sfigura nella vasta schiera barocca, in cui la metafora, il riferimento mitologico e i giochi di parola sono, com’è noto, gli ingredienti immancabili. Sarebbe, tuttavia, riduttivo declassare il suo spessore all’ossequio a certi canoni dominanti nella cultura del tempo, se non si cogliesse, emergente, come vedremo, qua e là, l’originalità dell’invenzione, alla quale, poi, la tecnica è asservita.
Questo autore è Giuseppe Domenichi Fapane di Copertino, sul quale è in avanzata fase di realizzazione un lavoro monografico. Qui basti dire che coltivò in modo quasi privilegiato l’epigramma e i sei volumi di Castaliae stillulae1 videro la luce in tempi diversi: il prImo per i tipi di Pietro Micheli a Lecce nel 1654; il secondo per i tipi di Luca Antonio Fusco a Napoli nel 1658, il terzo per i tipi di Paolo Frambotti a Padova nel 1659; il quarto per i tipi degli Eredi di Paolo Vigna a Parma nel 1662; il quinto per i tipi di Sermantelli a Firenze nel 1667 e il sesto per i tipi di Ambrogio De Vincentiis a Genova nel 1671. L’OPAC registra per il primo e per il terzo volume la presenza di un esemplare a Bari e di un’altro a Lecce; per il quarto uno solo a Lecce; per il quinto uno a Lecce e l’altro a Napoli; nessun esemplare risulta registrato per il secondo e per il sesto volume. Si tratta, dunque, di un libro rarissimo e quest’aggettivo va ridimensionato in unico per quanto riguarda il sesto volume che, irreperibile nell’OPAC, è custodito, invece, nella Biblioteca comunale “Achille Vergari” di Nardò (XLIV A-24). Ne riproduciamo di seguito il frontespizio.

Vi si legge: Castaliae stillulae quingentae quae sextum rivulum Permessi conficiunt hoc est epigrammaton Iosephi Domenichi Fapanis à Cupertino liber sextus. Venetiae. Apud Io(hannem) Ambrosium De Vincentiis. 1671 (Cinquecento gocce di Castalia che costituiscono il sesto ruscelletto del Permesso2, cioè il libro VI degli epigrammi di Giuseppe Domenichi Fapane da Copertino. Genova, Presso Giovanni Ambrogio De Vincentiis. 1671).
Segue una tavola con replica sintetica in alto a destra del titolo dell’opera (CASTALIA) e del nome dell’autore (DOMENICHI) e in basso a sinistra il numero del volume (LIBER VI).

Segue la dedica PERILLUSTRI DOMINO LAURENTIO CRASSO MAGNO VIRO virtute maximo (All’illustrissimo don Lorenzo Grasso3 grande uomo, grandissimo per valore).
Le pagine 193-207 contengono quindici epigrammi (come per gli altri il metro è il distico elegiaco) dedicati a Galeazzo Gaetano Pinelli, figlio di Cosimo (+ 1685) e di Anna Maria Ravaschieri4. Di questi epigrammi quattordici traggono spunto da un episodio sacro di cui si dirà e solo l’ultimo rientra nei canoni della poesie encomiastica. Li presento in una sorta di piccola antologia nel testo originale che ho provveduto a dotare della mia traduzione e delle mie note di commento.
1) MATER HEBRAEA in obsidio Solymae Filium trucidans DOMINO GALEATIO PINELLO Galatulae Marchioni, Cosmae Ducis Acherintiae filio, Domino, et Patrono
Devoro, quem genui: Genitrix, Homicida Vicissim;/cogit et ad facinus, quod mea cordas? fames./Impia nec dicar, fili; mea viscera prendo;/de me sumpsisti tu tamen ista, tibi./Exigo, quod tribui, debes, bone parvule, Vitam;/restituas Ventri, quae tibi Ventre dedi.
LA MADRE EBREA che nell’assedio di Gerusalemme trucida il figlio5. A DON GALEAZZO PINELLI marchese di Galatone, figlio di Cosimo duca di Acerenza, signore e protettore
Divoro colui che ho generato, io a turno genitrice e omicida. Mi costringe pure alla scelleratezza, perché mio cuore?, la fame. E non sia detta empia, o figlio: prendo le mie viscere; da me tuttavia tu le prendesti per te. Mi riprendo, buon fanciullo, tu lo devi, la vita che ti ho dato, Restituisci al ventre ciò che col ventre t’ho dato.
2) Saeva fames urget, matrem consumere Natum;/Viscera Visceribus, te mea, condo meis./Vivere ni poteris, saltem des funere Vitam;/ne te, quae fecit Vivere, Viva cadat./Crudelem fortasse Vocas? crudelis et ipse;/ni tibi fata paro; tù mihi tata paras.
Una fame feroce incalza una madre a divorare il figlio. Metto le mie viscere nelle mie viscere. Se non potrai vivere, almeno possa tu dare la vita con la morte, perché non cada da viva colei che ti fece vivere. Forse mi chiami crudele? Crudele è pure tu: se non ti procuro la fine tu la procuri a me.
3) Mando meum Genitum; proprio quem lacte nutrivi;/ne paream Genitrix Viscera sumo mea./Prodiit ex Utero: redeat tumulatus in Alvum;/Cunarumque locus, sit sibi tumba levis./Quid dicet Natura dolens? moriremur uterque./Expedit, ut Genitus pro Genitrice cadat.
Mangio mio figlio, che ho nutrito col mio latte, per non sembrare genitrice consumo le mie viscere. È uscito dal mio utero, ritorni tumulato nel ventre e il luogo del nido gli sia tomba leggera. Che dirà la natura dolente? Moriremo entrambi. Conviene che il figlio muoia per6 la madre.
4) Fili, mater obit: debes quoque fata subire/.neuter erit, possit qui superare famem./Si moriar, moreris.Vivam? moriare, necesse est,/alteruter nostrum contumulandus erit./Condo te in hoc Utero: me tù dum condere nescis./Quique magis debet, convenit ante Mori./
Figlio, la madre muore; devi subire pure tu lo stesso destino. Non ci sarà nessuno dei due che possa vincere la fame. Se morirò, morirai, Vivrò? Muoia tu!, è necessario, l’uno o l’altro dovrà essere sepolto insieme, Ti seppellisco in quest’utero, mentre tu non sai seppellire me e chi è maggiormente in debito è opportuno che muoia prima.
5) Nate, meus sanguis; miserae succurre Parenti;/quam male suada fames nunc iugulare parat;/ si bene quod de tè merui, nunc reddere oportet;/nec poteris matris tù superesse malis./Ut Vivam, pereas, potero sic esse superstes;/et Geniti dicar morte, renata Parens.
Figlio, mio sangue, aiuta la misera madre che la malamente persuasiva fame ora si prepara ad uccidere. Se bene qualcosa pe te ho meritato, ora è necessario renderlo. Né tu potresti sipravvivere alla sventura della madre. Muori tu affinché io viva, così potrò essere superstite e grazie alla morte del figlio sarò chiamata madre rinata.
6) Ecce homicida ferox: cultro te mactat acuto;/ut saturet, fili, sic moribunda famem./Materno hoc debet sanè gaudere sepulchro;/Gaudet, ut haec secum te tumulare Parens,/Conficior miserè: tecum nec vivere possum,/nec sinè te; mecum vivere, Nate, Velis.
Ecco la feroce omicida: ti uccide con l’acuminato coltello, perché, figlio, io moribonda sazi la fame. Devi senz’aktro godere di questo sepolcro materno, come gode questa madre a seppellirti con sé. Soffro miseramente: né posso vivere con te né senza di te. O figlio, tu vorresti vivere con me.
7) Eia peri! saeva haec tempus spectacula poscit;/viscera, quae genuit matre voranda manent;/impietatis opus mandrtur sorte futuris;/ut genuisse satis, sic necuisse fui./Morior crassante fame. Non parcere Matri,/illa potest: Nato cur moribunda Parens?
Ah, muoio! Il tempo richiede questo crudele soettacolo.Restano le viscere da divorare dalla madre che le ha generate. Sia consegnata dalla sorte ai posteri il gesto di empietà, Come sono stata sufficiente ad aver generato, così ad aver ucciso. Muoio per la fame che cresce. Non risparmiare la madre, essa può. Perché per un figlio una madre moribonda?
8) Ne moriar miserè, miserè te occidere oportet/;Nate, meum Viscus impia fata feras?/Iam periisse fame, Vilisque miserrima, res est;/Ferro etenim praestat; nobiliusque mori./Hinc iugulans te dedo neci; dicaris, ut ipse,/Matrem servasse , et te eripuisse malis.
Perché io non muoia miseramente bisogna uccidere te. Figlio, cuore mio, tu sopporteresti un empio destino? Già esser morti per fame è cosa vilie e miserrima; infatti conviene ed è più nobile morire di spada. Perciò uccidendoti ti consegno alla morte. Si dirà come tu stesso abbia salvato la madre e ti sia sottratto alla sventura.
9) Hic periisse fame, potes hic occumbere ferro;/elige fata, puer; mors subeunda quidem./Est obiisse fame, miserum; cadere ense, decorum;/hinc furit aegra lues, hic ferit alma Parens./Praestat honore mori, quam sic discedere inertem;/quam cadere invisum, praestat amore Mori.
Puoi morire qui di fame, lì soccombere alla spada. Scegli il destino, figlio; certamente si deve andare incontro alla morte. Cosa misera è morire di fame, decorosa soccombere cadere in combattimnto. Da una parte infuria una penosa calamità, dall’altra infierisce la madre che dà la vita. Conviene morire con onore che andarsene così inerte, che morire odiato. Conviene morire per amore.
Da notare il gioco di parole furit/ferit che si è tentato di conservare nella traduzione infuria/infierisce.
10) Debeo et ipsa fame consterni, Mater, atroci;/et Genitus matri tristè superstes erit?/Non! moriare Puer; des escam carne Parenti;( quae pia, lacte simul, haec tibi membra dedit./Horrendum fortasse putas animare sepulchrum?/Quam magis horrendum, te examinare7 fame./
Debbo pure io madre essere abbattuta da una fame atroce e il figlio sarà tristemente superstite alla madre? No! Muori tu, fanciullo, Con la tua carne dà cibo alla madre che affettuosa col latte ti diede nello stesso tempo queste membra. Forse ritieni orrendo dar vita ad un sepolcro? Quanto è più orrendo chetu muoia!
11) Trado neci Genitum: Iugulo mea Viscera Mater;/liberer ut dira morte, peresa fame/.Tite,cape ex Solymae nunc obsidione Trophaeum;/nam mea dextra facit, quod tua dextra nequit,/Me saevam fortassis habes? te appello Tyrannum;/quando paras Hostes sic iugulare tuos,/Viva, Triumphales possem conducere Currus;/mortua, nec fastus concelebrare tuos./Pupus iners fuerat pompae, si mater obiret;/nam foret extinctus, me pereunte, puer./Expedit iste cadat, sequar ipsa ut moesta Triumphos;ut tibi multiolicem carmina, scissa comas./Debellare cupis Solimae, Rex maxime, Muros;/an Solymae Cives sub iugo habere tuo?/Sic credam, macto ergo meum generosa Virago/quem genui; hic alios nam generare queo./At quid stulta loquir, consumens tempora? in orbe/nonne unum praestat, quam periisse duos?/Lege famis rabidae crescet tuus iste Triumphus;nam vivet semper cum Genitrice Puer.
Mando a morte il figlio, io, madre, uccido le mie viscere perché, divorata dalla fame, sia liberata da una morte crudele. Tito, cogli ora il trofeo dall’assedio di Gerusalemme! Infatti ora la mia destra fa ciò che tu non puoi.Forse mi ritieni crudele? Io chiamo te tiranno quando ti appresti ad uccidere così i tuoi nemici. Non posso vivere, se crudele non sacrifico il piccoletto; e non puoi vincere anche le donne ebree. Da viva potrei seguire i carri trionfali, da morta neppure celebrare i tuoi fasti. Il bambino inerte sarebbe dello spettacolo se la madre morisse; infatti, morendo io, sarebbe stato destinto a morire. Conviene che egli muoia perché io segua mesta i trionfi, perché con i capelli scompigliati moltiplichi per te i canti. Tu, re grandissimo, desideri sconfiggere le mura di Gerusalemme oppure tenere sotto il tuo giogo i cittadini di Gerusalemme? Così crederei, perciò io, generosa eroina, sacrifico colui che ho generato; qui infatti posso generarne altri. Ma, stupida, che dico, perderò tempo? Non conviene forse che al mondo ne muoia uno piuttosto che due? Questo tuo trionfo cresce per la legge della rabbiosa fame; infatti il figlio vivrà sempre con la madre.
12) Quid facis aegra parens? moriturus cedere debet/nunc puer iste; Velis tu properare necem,/sentiet et Titus saevos fortasse furores:/dum nescit nato parcere matris Amor./Pupus abest cum morte malis: tù mortis ab ore;/quos timuisse modos, corda Tyranna, solent.
Che fai, infelice madre? Ora questo fanciullo destinato a morire deve sparire. Tu vorresti affrettare la morte; forse anche Tito sentirà i crudeli furori, mentre l’amore di una madre non sa risparmiare il figlio. Il piccolo insieme la morte si sottrae alla sventura, tu dal volto della morte, confini che i cuori tiranni son soliti temere.
13) Quem paris, occidis: prodest genuisse; furorem/ut bene deludant, Viscera parta famis./Fertilitas ex Ventre iuvat; dat sanguinis escam;/cum steriles opus est occubuisse fame./Non moreris. Natus Ventri prius iste doloris/dira elementa, pius nunc alimenta dedit.
Uccidi quello che partorisci: giova l’aver generato affinché le viscere partorite opportunamente ingannino il furore della fame. L fertilità del ventre giova, dà l’alimento del sangue, mentre è sterile gesto morire di fame. Non morrai. Questo figlio prima ha procurato al ventre i tremendi sintomi del dolore, ora, generoso, l’alimento.
14) Mande, Parens, tua cara Caro est, quam lance reponis/.Sume cibum: scindas Viscera; pelle famem./Iam Genitum Vixisse sat est; tecumque Valebit/ vivere nunc iterum, cum moriturus erat./Crudelis pietas, natum consumere ad escam;/ut pia crudelitas, vivere velle malis.
Mangia, madre, è la tua cara carne quella che poni nel piatto. Prendi il cibo, scindi le viscere, respingi la fame! Già è sufficiente che tuo figli abbia vissuto con te; sarà capace ora di vivere per la seconda volta, quando era destinato a morire. Crudele pietà è consumare per cibo il figlio affinché, pia crudeltà, tu preferisca voler vivere.
15) EIDEM DOMINO MARCHIONI Primogenia virtute,8 Magno suapte Maximo
Pyrrhus Achilleides decoratus imagine Patris,/atque nepos Pelei, lumen utrisque fuit./Tu Ducis et Cosmae prognatus sanguine, et Annae/virtute illustras nomina Patris, Avi./Ille dedit galeam, Galeatius unde vocaris;/hic calamum, quo te, sic super astra, Vehis,/Hinc bene Mercurium possem te dicere: ni tu/solaris melius sphaera, vocandus eris./Et meritò, Mundus Pater est; tua Mater et Annus/splendere debebat solis imago suis.
AL MEDESIMO SIGNOR MARCHESE grande per il primigenio valore, grandissimo per il suo
Pirro9 discendente di Achille, onorato dall’immagine del padre, e nipote di Peleo, fu luce per entrambi. E tu generato dal sangue e del duca Cosimo e di Anna10, col valore illustri la fama il nome del padre, dell’avo. Quegli diede l’elmo, da cui sei chiamato Galeazzo11, questi la penna con cui ti spingi così al di sopra delle stelle. Perciò opportunamente potrei dirti Mercurio, se tu non dovessi essere chiamato meglio sfera solare. E meritatamente (tuo) padre è il mondo e tua madre l’anno. L’immagine del sole doveva splendere per i suoi.
Come il lettore avrà notato solo quest’ultimo epigramma può considerarsi direttamente celebrativo e contenente l’importante indicazione Ducis et Cosmae prognatus sanguine, et Annae, che integra, con citazione della madre, il Cosmae ducis Acherontiae filio che si legge in testa al primo epigramma.
A beneficio del lettore riportiamo ll ramo dell’albero dei Pinelli riferito ad un adeguato spazio temporale e costruito in base ai dati presenti in Vittorio Zacchino, Galatone antica medioevale moderna, Congedo, Galatina, 1990.

Tenendo presente la data di pubblicazione del volume del Fapane (1671), notiamo la presenza di Galeazzo Francesco (aggiungiamo I per distinguerlo dal successivo), Galeazzo Francesco (aggiungiamo II per distinguerlo dal precedente)12 e Galeazzo Antonio. Il Galeazzo celebrato dal Fapane, non fosse altro che per evidentissimi motivi cronologici, non può essere né Galeazzo Francesco (I) né Galeazzo Francesco (II), ma Galeazzo Antonio (figlio di Cosimo e di Anna Ravaschieri, come ricordato dal Fapane nell’ultimo epigramma). Tuttavia si legge in Vittorio Zacchino, op. cit. p. 178 che alla morte di Cosimo, avvenuta nel 1685, per essere fatuo il primogenito D. Galeazzo, il duca Gaetano fu dichiarato erede in feudalibus con decreto di Vicaria del 18 marzo \688, quindi titolare dello stato di Galatone.
Può sembrare a prima vista strano che il Fapane celebri, con lodi di ogni tipo, un fatuo. In italiano corrente fatuo, che è dal latino fatuu(m)=sciocco, insipido, è sinonimo di vuoto, superficiale. Risulta edulcorato, così, l’originario significato latino ereditato, invece, dal dialettale salentino fatu. Va precisato, altresì, che fatuo è voce tecnica, giuridica usata passato come sinonimo di mentecatto. infermo di mente, come si legge, per esempio, in Index omnium materiaru, quae in Venetiarum Statutis continentur, alphabetico ordine digestous, et per D. Andream Trivisanum iuris doctorem noviter in lucem editus, Comino de Tridino del Monferrato, Veneizia, 1548, p. 47: Si veramente il fatuo moriva avanti, che alcuno de li figlioli, overo discendenti mascoli de etade de anni 14 sarà pervenuto, over se ello non ha lassado dopo la soa morte alcun figlio, over descendente, il tutor allhora …
È probabile che alla data del 1671 la condizione mentale del ventenne Galeazzo Antonio non fosse ufficialmente nota e che per il Fapane egli fosse destinato ad essere l’erede di Cosimo. Sembra infatti quasi una damnatio memoriae,il fatto che il nome di Galeazzo non compaia tra quello dei figli di Cosimo in Casimiro di S. Maria Maddalena, Cronica della Provincia de’ Minori Osservanti Scalzi di S, Pietro d’Alcantara nel Regno di Napoli, Abbate, Napoli, 1729, tomo I, ove, a p, 176 si legge: Da Essi [Cosimo Pinelli e Anna Ravaschieri] nacquero D. Gaetano, D. Benedetto, D. Oronzio, e D. Daniello, oltre alle Femmine e perché D. Gaetano e D. Benedetto morirono giovani, li succedè il terzo fratello. Don Oronzio adunque fu quinto Marchese di Galatone, duca di Acerenza e principe di Belmonte.
Se la nostra ricostruzione è esatta, siamo in presenza di lodi che, pur sincere con tutti i limiti imposti dal do ut des ricordato all’inizio, alla luce della storia appaiono tragicamente grottesche.
___________
1 Alla lettera Piccole gocce di Castalia. Già nel titolo il richiamo al mito: Castalia era una ninfa, una delle tante vittime della lussuria di Apollo (la più famosa,è Dafne mutata in alloro), che, per sfuggire alle attenzioni del dio si gettò nella fonte Castalia sul monte Parnaso; secondo un’altra versione del mito fu Apollo a tramutarla in una fonte, alle cui acque conferì il potere di far diventare poeta chiunque vavesse bevuto la sua acqua. Per le altre opere e per alcuni componimenti sparsi in varie raccolte altrui vedi https://www.fondazioneterradotranto.it/2017/11/13/copertino-un-suo-figlio-marinista-giuseppe-domenichi-fapane/
2 Fiume della Beozia sacro alle Muse, che nasce sull’Elicona.
3 Autore di Epistole heroiche, Baba, Venezia, 1655; Istoria de’ poeti Greci e di que’ che in Greca lingua han poetato, Bulifon, Napoli, 1678; Elogii d’huomini letterati, Comi & La Noù, Venezia, 1666; Vita di S. Rocco, Conzatti, Venezia, 1666.
4 Per le loro nozze il neretino Antonio Caraccio scrisse l’epitalamio Il Fosforo (Micheli, Lecce, 1650).
5 L’episodio dell’ebrea che durante l’assedio i Gerusalemme ad opera di Tito, vinta dalla fame, divorò un figlioletto è in Giuseppe Ebreo, VIII, 13.
6 Con lo stesso valore ambiguo, che qui stupendamente conserva. del latino pro che può significare tanto a vantaggio di quanto al posto di.
7 Errore, probabilmente di stampa, per exanimare.
8 Questa virgola va spostata dopo Magno.
9 Appellativo di Neottolemo, figlio si Achille, a sua volta figlio di Peleo e Teti.
10 Come detto all’inizio, Anna Maria Ravaschieri.
11 Fatto derivare dal latino galeatus=munito di elmo, participio passato di galeare, a sua volta da galea=elmo di cuoio.
12 A Galeazzo Francesco (II) un altro salentino, il Galatonese Giovanni Pietro D’Alessandro (1574-1649) più di mezzo secolo prima aveva dedicato il poema Hierosolymae eversae, uscito per i tipi di Gargano e Nucci a Napoli nel 1613. inoltre a sua moglie Livia Squarciafico e al loro figlio Cosino il D’Alessandro aveva dedicato alcuni epigrammi. Di questi tratteremo a breve in un altro post, mentre ci pare opportuno dire qui qualcosa in più sul poema.

Hierosolymae eversae Io(hannis) Petri de Alexandro iure consulti Galatei, et academici Ociosi libri decem ad illustrissimum Galeatium Franciscum Pinellum III, Acheruntiae ducem, et Galatulae marchionem. Neapoli In typographia Ioannis Baptistae Gargani & Lucretii Nucci. MDCXIII (I dieci libri della Gerusalemme abbattuta di Giovanni Pietro D’Alessandro giureconsulto galatonese e accademico oziosoa per l’illustrissimo Galeazzo Francesco Pinelli terzo duca di Acerenza e marchese di Galatone. A Napoli.nella tipografia di Giovanni Battissta Gargano e Lucrezio Nucco. 1613).
In basso lo stemma della famiglia Pinelli: scudo con sei pigne poste 3, 2, 1 e sormontato dalla corona ducale.
Riportiamo integralmente, con la nostra traduzione, la dedica che precede il testo del poema, anche perché potrebbe essere di non non poco aiuto, data l’affidabilità dovuta non solo alla cronologia (quanto più passa il tempo più diventa problematica la ricostruzione storica) ma anche al fatto che il dedicante non poteva certo inventarsi balle, a diradare qualche dubbio o a correggere qualche errore dovuto a confusione per omonimia, tutt’altro che infrequente nella ricostruzioni genealogiche.
Illustrissimo Domino Galeatio Francisco Pinello III Acheruntiae duci, et Galatulae marchioni, etc. Natura comparatum est, ut unius resolutio sit planè alterius rei generatio, quo sanè in Ecclesiae Dei Naturae parentis satis conspicuo exemplo est nobis compertum. Eversa enim funditus terrena Christiani nominis hoste, Sacra paulatim consurgit Hierosolyma, eiusdem assertrix, ut potè Catholicae Ecclesiae incrementu, et splendor. Id quod inter primarias Christiani Orbis familias non parum videtur auxisse PINELLA gens tua, summorum nimirum praesulum mater (Dux Illustrissime) ex his plurimum sibi vendicat BAPTISTA ille Pinellus immortalis memoriae Consentinus antistes Innocentii VIII Summi Pont(ificis) nepos, cuius virtus in dioecesi lustranda, moribus emendandis collapsa Ecclesiae disciplina erigenda; Templis exstruendis, xenodochiis instaurandis, egentium inopia sub levanda ita enituit, magnique viri Religio, pietas, prudentia, solertia eò ssanctitatis excrevit, ut in tantis saeculi tenebris non secus, ac divinum quodam lumen effulserit, utque meritò Brutii tanti praesulis memoriam cum Divorum veneratione propè coniunxerint. Huius pronepos DOMINICUS Romam in Aula diù versatus gravissimis Catholicae Ecclesiae muneribus obeundis ita respondit, ut ad Sacrae purpurae apicem, mox ad Collegii Principatum evectus fuerit. Quorum vestigiis planè inhaesit IOANNES VINCENTIUS Illustrissimi genitoris tui patruus, in quo exornando (npvit tota Italia, novit universa Europa) immensa scientiarum moles cum religione, et prudentia certarunt. Neque verò caeteros, Illustrissimae familiae tuae Regulos seculari ditione praestantes omittam, quippè qui et ipsi religione, iustitia, pietate, fortitudine Christianae Reipublicae administrandae, eidemque defendendae maximo sunt decori, et adiuvamento. Hos inter eminet BARTHOLOMEUS Pinellus strenuus militiae Dux idemque summae pietatis Haeros, qui ducentis fermè ab hinc annis contrà summos Reges pro Ecclesiae libertate arma induere non est veritus. Mitto COSMUM seniorem, cuius eximia in tàm magna fortunae amplitudine, animi moderatio patruum nostrorum aetati conspecta, et posteritati in primis est memorabilis, COSMO GALEATIUS avus tuus est genitus, quem non magis paternae peramplae ditiones, quam suae ipsius virtutes, et merita extulerunt. Is omnia vitae munera persanctè implevit, prpinquos, et amicos liberalitate, et hospitalitate iuvit, subditis aequitate,iustitia, charitate imperavit, et Catholico PHILIPPO REGI II fidelem, et strenuam bello operam saepiùs navavit, quem Rex grato animo prosecutus Turonensis ditionis MARCHIONEM, MOX ACHERAUNTIAE Ducem creavit. De Illustrissimo autem COSMO psatre tuo Acheruntiae Duce, et Galatulae Marchione quis noster erit semo, quod nam principium, quis nam finis? Satius est tacere, quam in tàm vasto laudum pelago pauca dicere. Quis enim eius in Deum religione, Templaque per ipsum innumerabilibus impensis Deo dicata, et immodica per eundem piè legata miserabilibus, et egenis, in amicos, propinquos, et subditos eiusdem pietatem, generositatem, caeterasquw animi, et corporis dotes, quis scientiarum numeros, quibus undique enituit enarrare valeat? Quisvè eius inarmis praestantiam satis commendet, quam cum multa alia, tùm potissimum expeditio contrà turcas diebus fermè nostris aoud Tarentumostendit? Quis denique grave, et cum primis perspicax in arduis, maximisque rebus consilium praedicare satis praesumat? Ut non immerità à PHILIPPO III Augustissimo Magni Cancellariatus munere in Regno Neapolitano insigniri promeritus fuerit. Caeterum in te (Dux Illustrissime) contestatam maiorum tuorum in Deum religionem, animi candorem, morum suavitatem, gravitatem, totiusque vitae integritatem, quibus summa ingenii felicitas, et scientiarum in tenera adhuc aetate non levis cognitio accessit, estnè aliquis qui non admiretur, ac tantas animi tui et corporis dotes non colat, et recolat? Neque tantum paterna gens tua, sed et Illustrissima materna Grilla familia summa praestitit religionis dignitate; ex ea enim (materno latere) ortus est summus ille, et nunquam satis laudatus Catholicae pietatis assertor. Innocentius IIII aeternae memoriae Christi Vicarius, ut caeteros eiusdem Illustrissimae familiae S. R. E. Cardinales, et meritissimos praesules, et Haeroes toga, et armis clarissimos omittam. Iam verò pium EVERSAE HIEROSOLYMAE poema à me summis vigiliis elaboratum tibi pietate, et religione insigni Regulo, et ex antiquissima, et nobilissima familia longa piorum Haeroum serie sacrae Hierosolymae instauratrice progenito consecrare opere pretium duxi, quod praeterea naturalis mei erga te debiti, et Regii iuris obsequium postulat. Sume igitur hilari fronte (mi Dux, et Maecenas) addictissimi servi munus, tibi uni iure optimo omnique ex parte debitum. Deus Optimus Maximus te incolumem diutissimà servet, vota secundet, et ad maiora evehat. Neapoli Nonis Maii MDCXIII. Servus humilissimus Io(hannes) de Alexandro i(uris) C(onsultus) Galateus.
All’illustrissimo don Galeazzo Pinelli terzo duca di Acerenza e marchese di Galatone etc.
Dalla natura fu disposto che la conclusione di un fatto fosse chiaramente l’origine di un altro, come da noi fu scoerto senza dubbio nell’esempio abbastanza cospicuo della Chiesa di Dio padre della natura. La sacra terrena Gerusalemme di nome cristiano, infatti, abbattuta dalle fondamenta dal nemico a poco a poco risorge a sua difesa come potente incremento e splendore della Chiesa cattolica, cosa che non poco sembra aver accresciuto tra le primarie famiglie del mondo cristiano la tua famiglia Pinelli. madre di presuli certamente grandissimi (o duca illustrissimo), tra i quali rivendica a sé soprattutto quel Battista Pinelli d’immortale memoria arcivescovo di Cosenzab, nipote del sommo pontefice Innocenzo VIII. la cui virtù nel curare la diocesi, nel correggere i costumi, nel ripristinare la disciplina della chiesa venuta meno, nel costruire templi, nel restaurare foresterie, nell’alleviare la mancanza di mezzi dei bisognosi tanto brillò e la religiosità, la generosità, la prudenza e la solerzia di un uomo magnifico giunse a tal livello di santità che nelle tante tenebre del secolo risplendette non diversamenre da una luce divina e meritatamente i calabresi congiunsero quasi la memoria di un presule così grande con la venerazione degli Dei. Il pronipote di questi Domenicoc impegnato a lungo a Roma nell’affrontare pesantissimi incarichi della chiesa cattolica rispose così bene che fu innalzato al titolo della sacra porpora, poi alla direzione del Collegio. Di loro seguì certamente le orme Giovanni Vincenzo, zio del tuo illustrissimo padre, nel quale a distinguerlo (lo sa tutta l’Italia, lo sa l’Europa intera) l’immensa mole di conoscenza e la prudenza gareggiarono con la religiosità. Né certamente passerò sotto silenzio gli altri principid che si distinsero per potere secolare, i quali certamente pure loro per religiosità, giustizia, generosità, forza sono di massimo decoro ed aiuto ad amministrare lo stato cristiano ed a difendere lo stesso. Tra questi spicca Bartolomeo Pinelli strenuo comandante militare ed egli stesso eroe di somma generosità, che circa duecento anni fa non ebbe paura ad indossare le armi contro sommi re per la libertà della Chiesa. Aggiungo Cosimo il vecchio, la cui esimia moderazione d’animo in tanta ampiezza di fortuna, ben nota al tempo dei nostri padri, è memorabile sopra ogni altra anche per la posterità. Da Cosimo fu generato il tuo avo Galeazzo, che gli amplissimi poteri paterni elevarono non più delle sue virtù, e meritatamente. Egli santissimamente espletò tutti i doveri della vita, aiutò i congiunti e gli amici con generosità ed ospitalità, comandò i sudditi con equità, giustizia, carità e, fedele al re cattolico Filippo II più volte prestò anche la sua coraggiosa opera in guerra. Il re apprezzando con animo grato lo creò marchese del dominio di Tursie, poi duca di Acerenza. Sull’illustrissimo padre tuo Cosimo duca di Acerenza e marchese di Galatone quale sarà poi il nostro discorso, quale il principio, quale la fine? Sarebbe preferibile tacere che dire poco in un mare così vasto di lodi. Chi infatti sarebbe in grado di passare in rassegna la sua devozione a Dio, i templi da lui dedicati a Dio con incalcolabili spese, i non modesti suoi lasciti generosamente fatti a favore dei miseri e bisognosi , il suo affetto, la generosità e le altre doti dell’animo e del corpo nei confronti degli amici, dei parenti e dei sudditi, chi l’ampiezza di conoscenza, per le quali cose si distinse dappertutto? O chi potrebbe illustrare il suo valore nelle armi che tanto molte altre gesta quanto soprattutto la spedizione quasi ai nostri giorni contro i Turchi presso Taranto mostra?f Chi infine potrebbe presumere di celebrare a sufficienza insieme con le cose dette prima la saggezza profonda e perspicace in circostanze difficili e importantissime? Sicché non immeritatamente ottenne di essere insignito dell’incarico del gran cancelliarato nel regno di Napoli dll’augustissimo Filippo III. Del resto c’è forse chi non ammiri in te (o duca illustrissimo) la testimoniata devozione in Dio dei tuoi avi, il candore dell’animo, la dolcezza dei costumi, la serietà e l’integrità di tutta la vita, cui si aggiunse la fortuna di un sommo ingegno e fin dalla tenera età la conoscenza delle scienze, e non apprezzi e riapprezzi le doti così grandi del tuo animo e corpo? Nè solo la tua stirpe paterna ma anche l’illustrissima famiglia materna Grillog si distinse per la somma dignità della religiosità; da essa infatti (dal lato materno) nacque quel sommo e mai sufficientemente lodato difensore della religione cattolica Innocenzo III di eterna memoria vicario di Cristo, per non dire degli altri cardinali di Sacra Romana Chiesa e molto benemeriti presuli ed eroi famosissimi in pace e in guerra della stessa illustrissima famiglia. Infine ho considerato un privilegio consacrare con un’opera il poema religioso della Gerusalemme espugnata da me composto in lunghe veglie a te, principe insigne per generosità e religiosità e discendente da antichissima e nobilissima famiglia lunga serie di pii eroi, restauratrice della sacra Gerusalemme; questo inoltre richiede il rispetto del mio debito naturale verso te e del regio diritto. Accetta dunque di buon viso (o mio duca e mecenate) il dono di un servo obbligatissimo, a te solo dovuto a buon diritto e sotto ogni aspetto. Dio ottimo massimo ti conservi sano e salvo per lunghissimo tempo, assecondi i tuoi desideri e ti spinga ad imprese più grandi. Napoli, 7 maggio 1613. Umilissimo servo Giovanni De Alessandro giureconsulto di Galatone.
Per completezza aggiungiamo che Galeazzo Francesco (II) fu celebrato anche da Giovan Battista Basile (1566-1632) nell’ottava 49 del libro V del Teagene uscito postumo per i tipi del Facciotti a Napoli nel 1637: Un Galeazzo ancor prodigo altrui,/quanto largo di pregio ò lui fù ‘l Cielo,/non vedrà mai ne’ fatti incliti sui/giunger del Tempo, ò de la Morte il telo./O mille volte fortunati, à cui/dato in forte à vestir terranno velo/sarà in quei lieti, e fortunati giorni,/quando un sì vivo lume il Mondo adorni!
Il leccese Iacopo Antonio Ferrari (1507-1587), infine, gli dedicò Antichità di Napoli (rimasto manoscritto) secondo quanto si legge nell’Apologia paradossica pubblicata postuma per i tipi di Mazzei a Lecce nel 1707: … ed avendo poi io scritta al mio libro dell’antichità di Napoli all’illustre Signor Marchese di Galatole Galeazzo Pinello…
Nell’immagine che segue, tratta da Scipione Mazzella, Desxcittione del Regno di Napoli, Cappelli, 1586, p. 426, lo stemma di Galeazzo Pinelli marchese di Tursi.

______________
a L’accademia degli Oziosi fu fondata a Napoli nel 1611. Tra i suoi membri più illustri annoverò Giulio Cesare Capaccio, Giambattista Basile e Tommaso Campanella. Il D’Alessandro, oltre a Hierosolymae eversae pubblicò pure: Dimostratione di luoghi tolti , et imitati da più autori dal Sig. Torquato Tasso nel Gofredo, overo Gerusalemme liberata, Vitale, Napoli, 1604 (dedicato a Girolamo De Monti marchese di Corigliano); Academiae Ociosorum libri III, Gargani e Nucci, Napoli, 1613 (dedicato a Pietro Ferdinando Castro marchese di Lemos e vicerè del Regno di Napoli); Arnus, Micheli, Lecce, 1636 (dedicato al cardinale Antonio Barberini, Suoi epigrammi in latino sono presenti in Alessandro Tommaso Arcudi, Galatina letterata, Celle, Genova 1709 (uno a p. 34 dedicato a Silvio Arcudi, un altro a p. 52 dedicato a Tommaso Cavazza (ma quest’ultimo epigramma era già uscito nella seione Epigrammatum liber posta in coda alla Dimostrazione di luoghi …, op. cit., p. 259); nella seconda parte della raccolta dedicata alle Esequie della Serenissima Reina Margherita d’Austria, Longp, Napoli, 1612, p. 29 (un centone virgiliano di 91 esametri); in Giulio Cesare Grandi, Varii componimenti volgari, e latini in lode dell’illustrissimo signor Don Francesco Lanario, et Aragona hora Duca di Carpignano , Cavaliero dell’habito di Calatrava, e del Consiglio di Guerra di Sua Maestà Cattolica ne’ stati di Fiandra, Governator Generale della Provintia di Terra d’Otranto, con la potestà ad modum belli, Cirillo, Palermo, 1621 (uno a p. 37) ; in Francesco Antonio Core, Historia della imagine miracolosa del Glorioso Crocifisso della Pietà riverito nella Terra di Galatone, Roncagliolo, Napoli, 1625 .
b Dal 1491 al 1495.
c (1541-1611) nel 1563 entrò come referendario nel Supremo tribunale della Segnatura apostolica; nel 1585 Sisto V lo nominò cardinale, nel 1607 divenne decano dell’ordine cardinalizio.
d Traduciamo così Regulos che alla lettera significa reuccio e che qui ha solo un valore distintivo rispetto ai rappresentanti religiosi della famiglia.
e Crediamo che il Turonensis del testo sia un errore di stampa per Tursonensis.
f Il tarantino Cataldo Antonio Mannarino nella sua Oligantea delle lodi di Alberto I Acquaviva d’Aragonam, Carlini e Pace, Napoli, 1596.
g Cosimo Pinelli aveva sposato Nicoletta Grillo nel 1588. Data la minore età, Francesco Galeazzo alla morte del padre (1601 o 1602)) aveva assunto il feudo sotto la tutela della madre.